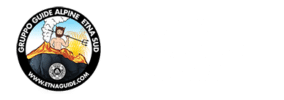La Valle del Bove è una vasta depressione situata sul versante orientale dell’Etna, caratterizzata da una forma a ferro di cavallo e completamente ricoperta da colate laviche generate da eruzioni laterali avvenute nel corso degli ultimi secoli. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la sua formazione è il risultato di fenomeni di collasso multiplo del fianco orientale dell’Etna e di successivi processi erosionali avvenuti durante l’Olocene.
Recenti studi condotti dall’INGV, hanno permesso di datare per la prima volta in maniera assoluta l’età dell’inizio della formazione della Valle del Bove.
Grazie a indagini stratigrafiche e petrografiche, datazioni al carbonio-14 e paleomagnetiche delle colate laviche, è stato possibile determinare che la valle si è formata tra il 7478 e il 7134 a.C. In particolare, la fase iniziale della formazione della valle è dovuta a un grande collasso di fianco dell’edificio vulcanico che ha prodotto un vasto deposito detritico nell’area dell’abitato di Milo, estendendosi per circa 4,3 km².
Le analisi paleomagnetiche hanno inoltre evidenziato che, durante gli ultimi 4000 anni, si sono verificate due eruzioni laterali durante la tarda età del Rame (2600-2400 a.C.) e altre due eruzioni laterali, non riportate nelle fonti storiche, avvenute in epoca Greco-Romana e Medievale.



Valle del Bove: morfologia e caratteristiche attuali
La Valle del Bove si presenta oggi come un ambiente desertico, ricoperto da colate laviche recenti, tra cui quelle dell’eruzione del 1991-1993 che hanno ridisegnato l’aspetto della depressione. Occupa una superficie di circa 37 km², con un perimetro di circa 18 chilometri. Le pareti nord e sud della valle variano in altezza tra i 400 e i 1.000 metri, mentre a est si apre in una spianata interrotta dal Monte Calanna, che emerge isolato dalle recenti lave. Uno scosceso pendio, il Salto della Giumenta, la separa dalla sottostante Val Calanna.
Importanza scientifica della Valle del Bove
All’interno della valle sono presenti diverse “dagale”, ovvero porzioni di vegetazione isolata circondate da lave, e sono visibili alcuni crateri avventizi recenti, come Monte Simone (eruzione del 1811-1812) e i Monti Centenari (eruzione del 1852-1853). Sono inoltre presenti formazioni rocciose risalenti ai collassi del complesso vulcanico del Trifoglietto.
La Valle del Bove rappresenta un’area di grande interesse per gli studiosi dell’Etna, poiché consente di osservare le successioni stratigrafiche delle diverse fasi eruttive del vulcano. La sua morfologia e la presenza di depositi lavici e piroclastici offrono preziose informazioni sulla storia eruttiva e sui processi geologici che hanno modellato l’Etna nel corso dei millenni.